Prevenzione? No: istigazione al suicidio
Il racconto di Desirè Gloria Vasta: "Quando lo Stato ti costringe a rivedere i tuoi concetti di legalità"
Mi chiamo Desire’ Gloria Vasta, ho 27 anni e sono amministratore unico di una piccola impresa: la Divina Service s.r.l.s., un’azienda alla quale è stata insensatamente negata, dalla Prefettura di Caltanissetta, l’iscrizione alla white list.
Ciò che risulta veramente avvilente e mortificante è il dato argomentativo su cui si fonda il diniego, sintetizzabile in due assunti evidentemente privi di logica e di morale: sono ritenuta “troppo giovane” per svolgere attività imprenditoriale; sono figlia di mio padre.
Chi è mio padre? Mio padre è un uomo innocente, vessato e devastato dall’estorsione mafiosa e annientato dalla “giustizia” italiana.
Io avevo soltanto 12 anni quando, in una notte del novembre 2005, degli uomini in divisa mi privarono di mio padre per circa quattro anni. Di quella notte ricordo tutto: la casa sottosopra a causa della perquisizione, lo smarrimento e la tensione provata nel vedere degli agenti che si muovevano all’interno e all’esterno con una determinazione e padronanza degli ambienti che ci ha fatti sentire dei perfetti estranei nella nostra stessa abitazione. Insomma, un arresto degno di un capo mafia! Peccato che il destinatario del provvedimento dell’autorità giudiziaria fosse un uomo innocente, che a quei tempi subiva danneggiamenti di ogni genere ad opera della criminalità organizzata, dai furti agli incendi, e che puntualmente denunciava tutto alle autorità competenti.
In quella terribile notte furono molte le cose che mi segnarono indelebilmente. Ricordo le luci dei lampeggianti che illuminavano le nostre stanze e le parole che mio padre mi disse, abbracciandomi, prima di essere portato via: “non vergognarti mai di me, cammina a testa alta e stai vicina alla mamma, tutto si risolverà in pochi giorni”. Quei “pochi giorni”, in realtà, durarono anni.
Quei “pochi giorni”, in realtà, durarono anni.

Ma, soprattutto, ricordo la mia corsa per raggiungerlo quando stava salendo sull’auto che lo avrebbe portato via. A un certo punto mio fratello, prendendomi tra le sue braccia, mi tappò gli occhi, un gesto che tutt’oggi rimane per me incompreso ma carico di amore fraterno.
All’epoca mio fratello aveva 19 anni, studiava ingegneria idraulica ed eravamo tutti fieri e fiduciosi del fatto che presto avremmo avuto in famiglia un ingegnere specializzato nel settore che ha sempre appassionato mio padre: la costruzione di acquedotti e metanodotti. Ma quella notte tutto cambiò anche per mio fratello che dovette immediatamente abbandonare gli studi per prendere il posto di mio padre in azienda.
Le cose però andavano male e di male in peggio: appena un paio di mesi dopo l’arresto, l’azienda venne sequestrata. Ovviamente, come in un copione già scritto, l’amministratore giudiziario trasformò un’azienda florida in un cumulo di macerie. Capimmo subito che tutto sarebbe andato in rovina. Dopo appena due mesi, il nominato amministratore giudiziario smise di pagare gli stipendi. Ci trovammo senza mezzi di sostentamento e fummo costretti a trasferirci a casa dei miei nonni materni che in quel periodo ci sostennero economicamente e moralmente.
Furono anni duri, che segnarono inevitabilmente le nostre vite. Abbiamo vissuto un dolore e una disperazione che non scorderemo mai.
Un pomeriggio di febbraio, mentre stavamo pranzando, sentimmo squillare il telefono. Dall’altra parte del filo c’era mio padre che, tra le lacrime e con la voce rotta dall’emozione, ci annunciava la sua liberazione. Finalmente, era un uomo libero, era stata accertata e dichiarata la sua innocenza. La Corte di Appello di Caltanissetta, dopo quattro anni e mezzo di carcere, lo aveva assolto e aveva disposto la revoca immediata del sequestro dell’azienda, ormai irrimediabilmente compromessa.
Io avevo 16 anni e, da poco, ero diventata madre di una bellissima bambina che ho chiamato Gloria Divina.
Sembrava un meraviglioso segnale di rinascita e di speranza e, sull’onda dell’entusiasmo e con la fiducia nelle Istituzioni, nel luglio del 2010 mio fratello costituì una nuova società: la Divina Acquedotti s.r.l.. L’idea era quella di ricostruire laddove l’amministrazione giudiziaria aveva distrutto. Ci siamo messi subito all’opera con l’obiettivo di recuperare il tempo perduto, senza lesinare energie e sacrifici. Eravamo felici, la nostra vita sembrava poter riprendere il proprio corso.
Nella realtà, continuavamo a fare i conti con gli effetti devastanti della sciagurata gestione dell’amministratore giudiziario. Quest’ultimo aveva addirittura smesso di pagare il mutuo di casa nostra (che era stata precedentemente data in garanzia per un prestito aziendale). Così, dopo la revoca di sequestro dell’impresa, venute meno le tutele previste dalla legge, la banca la mise all’asta. Non è dato comprendere – e credo rimarrà un mistero – il modo in cui l’amministratore giudiziario ha gestito le sostanze di mio padre e della mia famiglia. Decidiamo comunque di farci coraggio e, tornando ad indebitarci, riuscimmo a venire a capo anche di quest’altro problema.
Il lavoro sembrava andare per il meglio tanto da far registrare una costante crescita, che permetteva di assicurare stabilità a ben quindici dipendenti. Fu anche studiato un programma aziendale che si poneva l’obiettivo di partecipare a qualche bando di gara: i requisiti c’erano tutti, mancava soltanto l’iscrizione alla white list, la cui disciplina era entrata in vigore da poco. Ma, ahimè, l’iscrizione venne subito immotivatamente negata.
Infatti, la prefettura di Caltanissetta emetteva un’interdittiva nei confronti di mio fratello e, di conseguenza, la società di cui lui era a capo non poteva più lavorare con gli enti pubblici. Il motivo era che mio padre – accusato ingiustamente di mafia e poi definitivamente assolto – era il direttore tecnico dell’impresa. Evidentemente, il fatto di avere tra i propri dipendenti la vittima di un errore giudiziario, diventa motivo per polverizzare un’azienda e i sogni di riscatto di un’intera famiglia.
Faccio tutt’ora fatica a comprendere il criterio utilizzato dalla Prefettura, dato che non riesco a spiegarmi come sia possibile che un Tribunale assolve mio padre con formula piena mentre la Prefettura continua a considerarlo un mafioso.
A questo punto, mio fratello cade in uno stato di profonda depressione e di sconforto. Perseguitato da un sistema vessatorio che lo ha segnato nella mente e nel fisico, si dimette da amministratore. La società è nuovamente allo sbando, non per errori imprenditoriali o per cause di mala gestio, ma a causa dell’asfissiante ed ostinata opera di persecuzione attuata nei confronti della mia famiglia attraverso una legge degna dei peggiori regimi che conferisce alla Prefetture il potere di decidere la vita e la morte delle persone.
Quando mio fratello lasciò le redini dell’impresa per curare le ferite che questa situazione gli avevano lasciato nell’anima, compresi che io dovevo farmi avanti. Non potevo arrendermi.
Così ho costituito una nuova società: la Divina Service s.r.l.s.. Inizio a portarla avanti con coraggio e determinazione.
Avviata la nuova realtà imprenditoriale – che fa registrare sin da subito ottimi risultati – richiedo l’iscrizione alla white list, certa che uno Stato democratico come l’Italia, fondato sul lavoro, avrebbe premiato la volontà e la tenacia di una ragazza con voglia di fare.
Pare finanche superfluo specificare che avevo – e ho – bisogno di lavorare con gli enti pubblici, e che nel settore in cui operiamo l’iscrizione nella white list è fondamentale.
Nelle more della decisione della Prefettura, mio padre viene addirittura riconosciuto vittima di estorsioni mafiose da parte del Tribunale di Caltanissetta. Sembrava che la giustizia avesse finalmente fatto il suo corso: mio padre, inizialmente considerato mafioso, era stato riconosciuto vittima del sodalizio criminale. Si era solo confuso il bianco con il nero e, per una svista, un innocente vittima di estorsioni era stato sbattuto in galera come i suoi aguzzini.
“Sembrava” appunto. Tutto questo alla Prefettura non interessava, ed infatti anche per me arrivò puntuale, ed inesorabile, il diniego all’iscrizione alla white list.
Provo a resistere e faccio subito ricorso avverso il provvedimento di diniego, ma gli organi preposti non hanno tenuto conto delle memorie difensive del mio legale. La Prefettura si limita a rispondermi semplicemente con un altro rigetto, questa volta espresso in una relazione di 18 pagine. Non mi vengono attribuite particolari colpe se non quella di essere la figlia di un uomo che è risultato vittima di un mastodontico errore giudiziario e che è stato poi addirittura riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, “vittima di estorsioni mafiose”.
Per la Prefettura, è come se mio padre fosse un criminale sfuggito alle maglie della giustizia penale. E, come in una vendetta trasversale, merita di essere perseguitato e devono essere colpiti anche i suoi figli, magari i nipoti e, con loro, le future generazioni. Dell’eredità di mio padre, insomma, non deve rimanere niente. Bisogna fare terra bruciata attorno a lui e a tutti coloro che portano il cognome Vasta.
Quest’ulteriore cataclisma abbattutosi sulle mie speranze, sul mio impegno e sui miei sacrifici, oltre a non trovare alcuna spiegazione razionale, rischia di annientare definitivamente il mio futuro, quello dei miei 3 bambini e quello delle famiglie dei lavoratori dell’impresa.
Mio padre – un uomo che non si è mai arreso di fronte a nulla – vedendo lesa la mia persona e il mio sogno, ha patito un pesante contraccolpo psicologico. I sensi di colpa gli hanno divorato l’anima, portandolo a pensare di compiere un gesto estremo: il suicidio. Fortunatamente, l’amore per i suoi nipotini, per i miei figli e per i figli di mio fratello, lo hanno fatto desistere.
Il diniego della Prefettura potrà avere per alcuni il risibile rilievo di un mero e freddo adempimento burocratico, ma nel mondo reale esso assume un peso specifico che soffoca la speranza e distrugge le legittime aspettative di un’impresa e dei suoi dipendenti che vogliono solo lavorare.
Nulla potrà restituirmi gli anni della mia vita senza mio padre, però, perlomeno, uno Stato civile dovrebbe fermarsi, riconoscere i propri errori e aiutare i suoi cittadini riconosciuti innocenti dopo un lungo e sofferto calvario giudiziario. Uno Stato civile non può farmi vivere in un incubo terribile dove il mostro cattivo sembra, per assurdo, essere proprio lo Stato che mi condanna – senza una colpa – ad un futuro senza lavoro e, dunque, senza dignità.
Agli avvocati ho chiesto come sia possibile che in Italia vengano applicate misure così devastanti nei confronti di persone che non hanno commesso alcun reato. E loro mi hanno spiegato che, per i giudici, tutto sommato le interdittive non sono delle “sanzioni penali” e che, pertanto, possono essere applicate a prescindere dalla colpa, al di fuori di un normale processo penale. Ho il massimo rispetto nei confronti degli scienziati del diritto, ma simili affermazioni non tengono conto degli effetti che la privazione del lavoro provoca sulle persone. Forse è arrivato il momento di “scendere dalla luna” e di recuperare il senno che anni e anni di cieca propaganda antimafiosa hanno fatto perdere. È giunto il momento di passare da concetti astratti e vuoti alla concretezza della realtà, dalla filosofia e dall’ipocrisia alla carne viva della gente che soffre.
Non saranno “sanzioni penali” e questo poco importa. Rimane il fatto che le interdittive sono qualcosa di molto peggio: vere e proprie armi di distruzioni di massa che istigano al suicidio gli innocenti.
Ho deciso di affidare a Nessuno tocchi Caino la mia disperazione, cercando di descrivere il senso di vuoto e del dolore che l’applicazione di una legge ingiusta mi ha provocato.
Così non si fa la lotta alla mafia.
Così si annientano le persone.






 Carmela Barbara
Carmela Barbara



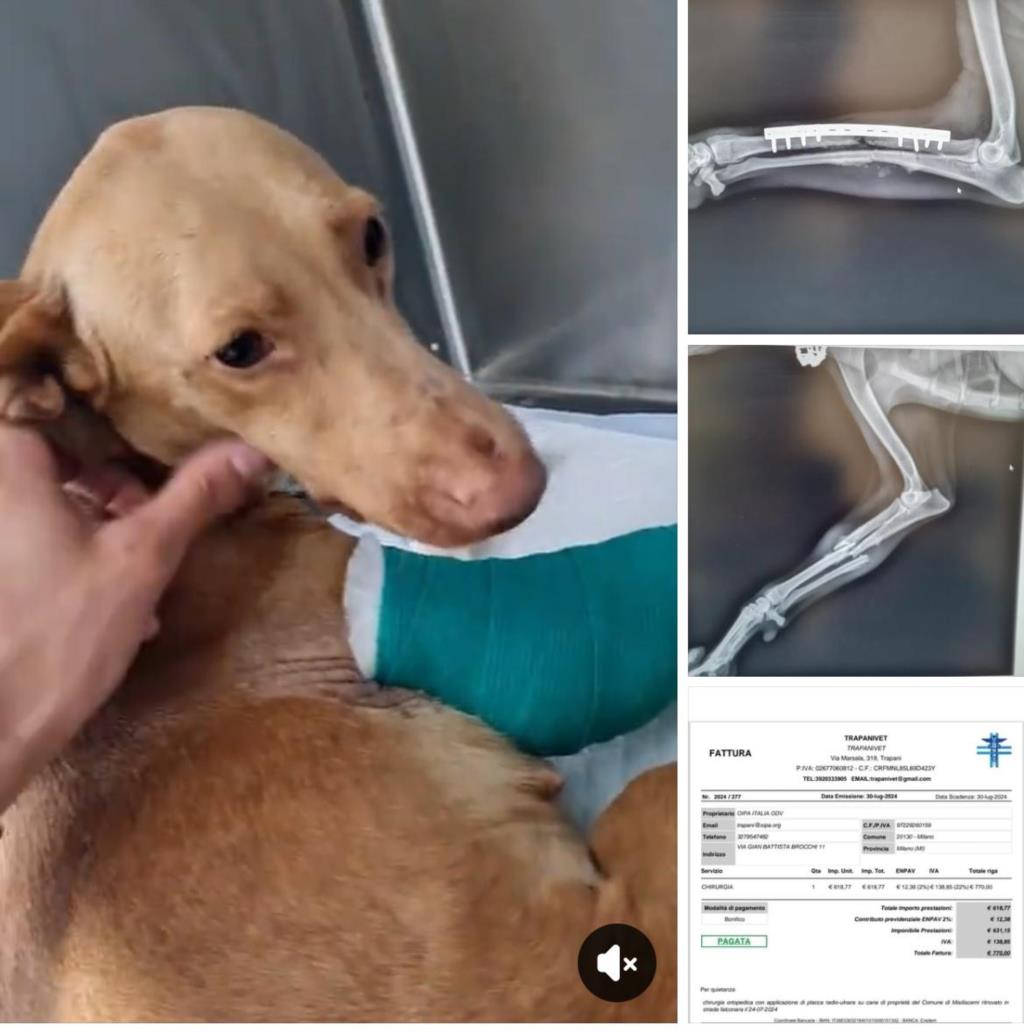


 Giusy Lombardo
Giusy Lombardo


