“Con affetto, l’Articolo 6”: la testimonianza di Chiara tra diagnosi, solitudine e ostacoli all’IVG
Una storia vera di dolore, determinazione e umanità negata, tra le pieghe di una legge la legge 194 del 78 che troppo spesso in Sicilia lascia sole le donne. Il nome della protagonista è di fantasia, per tutelarne la privacy
Una storia vera di dolore, determinazione e umanità negata, tra le pieghe di una legge la legge 194 del 78 che troppo spesso in Sicilia lascia sole le donne. Il nome della protagonista è di fantasia, per tutelarne la privacy.
Mi chiamo Chiara. Ottobre mi aveva regalato una notizia bellissima: ero incinta. Alla mia età, sapevo che non era scontato, e la gioia che ho provato nel vedere quel test positivo non la dimenticherò mai.
Alla prima visita, il ginecologo mi consigliò, per sicurezza, un test prenatale non invasivo. Nonostante il costo elevato, decisi di farlo all’undicesima settimana. Due settimane dopo, una telefonata cambiò tutto: il medico mi disse che c’era “qualcosa”, ma di non preoccuparmi. Incuriosita e inquieta, mi precipitai in ospedale, dove mi spiegò che era emersa una possibile anomalia genetica. Menzionò una sindrome, senza scendere troppo nei dettagli. Io, spaventata, chiesi cosa dovevo fare. La sua risposta, secca e quasi accusatoria, fu: “Nulla. Non vorrai mica interrompere?”. Era un obiettore di coscienza.
Tornai a casa distrutta e cercai informazioni. Piangevo, leggevo, cercavo risposte. Il giorno dopo presi appuntamento con una genetista in un ospedale pubblico. Mi ricevette insieme a un’altra dottoressa: professionali, chiare, umane. Volevo vederci chiaro. Consultai anche un altro centro. Dopo aver riflettuto profondamente, decisi di interrompere la gravidanza. Non era una scelta leggera. Non era una “fuga”. Era consapevolezza.
Ma il tempo non era dalla mia parte. Oltre i 90 giorni previsti dalla legge per l’interruzione volontaria di gravidanza, era necessario dimostrare una patologia genetica tramite esame diagnostico. Feci l’amniocentesi due settimane dopo, in un ospedale tra Trapani e Palermo, con un medico che mi trattò con rispetto e attenzione. Iniziò una corsa contro il tempo: sapevo che in Italia, superate le 23 settimane e 6 giorni, non avrei potuto più interrompere. Se non fosse arrivato in tempo il risultato, avrei preso un volo per la Spagna.
Dopo cinque lunghe settimane, arrivò la conferma della sindrome. Con quel referto in mano, mi recai all’ospedale. Mi indicarono cosa portare, mi fecero i primi controlli. Poi, l’unica ostetrica presente per i casi di interruzione terapeutica mi spiegò che avrei assunto delle pillole ogni tre ore, fino a indurre un piccolo travaglio. Tutto sarebbe avvenuto in stanza. Rimasi pietrificata.
Cominciò così un lungo calvario. Gli effetti collaterali erano pesanti. Passavano i giorni: uno, due, tre, quattro… ogni mattina il giro dei medici, ma per me era diverso. La mia compagna di stanza veniva ascoltata e visitata. Quando chiedevano di me, bastava sentir pronunciare “articolo 6” perché si voltassero e se ne andassero senza salutare. Come se non fossi una persona, ma un’etichetta, un peso.
Al quinto giorno, finalmente, un medico mi rivolse la parola. Si informò, mi ascoltò, mi rassicurò. Fu il primo gesto umano dopo giorni. Modificò la terapia, e quella sera iniziai il travaglio. I dolori arrivarono forti, incessanti. Alle 23 la mia compagna di stanza, preoccupata, chiamò l’infermiera. Mi visitarono, mi fecero una flebo e mi dissero che il feto era in posizione. Ma poi, più nulla. Il mio medico era in sala operatoria per un’urgenza. Gli altri erano lì, liberi… ma nessuno si avvicinò. Rimasi sola. Sentivo le loro voci, le loro risate nella stanza accanto. E io ero lì, in travaglio, dimenticata.
Alle otto del mattino entrò un’ostetrica. Lesse la mia cartella e, senza guardarmi, disse seccamente: “Devi andare in stanza. Sei articolo 6”. Provai a spiegare che stavo aspettando il mio medico. Lei lo chiamò, contrariata, e quando lui le confermò che dovevo restare, mi lanciò uno sguardo carico di rabbia.
Alle dieci, ormai stremata, provai ad alzarmi per andare in bagno. Un’altra ostetrica mi fermò con dolcezza. Mi visitò e capì che era il momento. Chiamò una dottoressa che le disse di procedere. Tre spinte. Tutto era finito. Lei fu gentile, presente, materna.
Durante quei giorni, per molti, non sono stata Chiara. Non sono stata una donna, una madre, una paziente. Ero solo un “articolo 6”. Un’etichetta che mi ha tolto voce, dignità, empatia.
Oggi ho un bambino piccolo, ed è la gioia della mia vita. Ma ho vissuto il terrore che, il giorno del parto, potesse esserci ancora quella stessa ostetrica. Per fortuna, non è successo. Ma la paura, e il dolore di quei giorni, non li dimenticherò mai.
Con affetto,
Chiara — una delle tante invisibili sotto l’etichetta “Articolo 6”.




 Redazione
Redazione



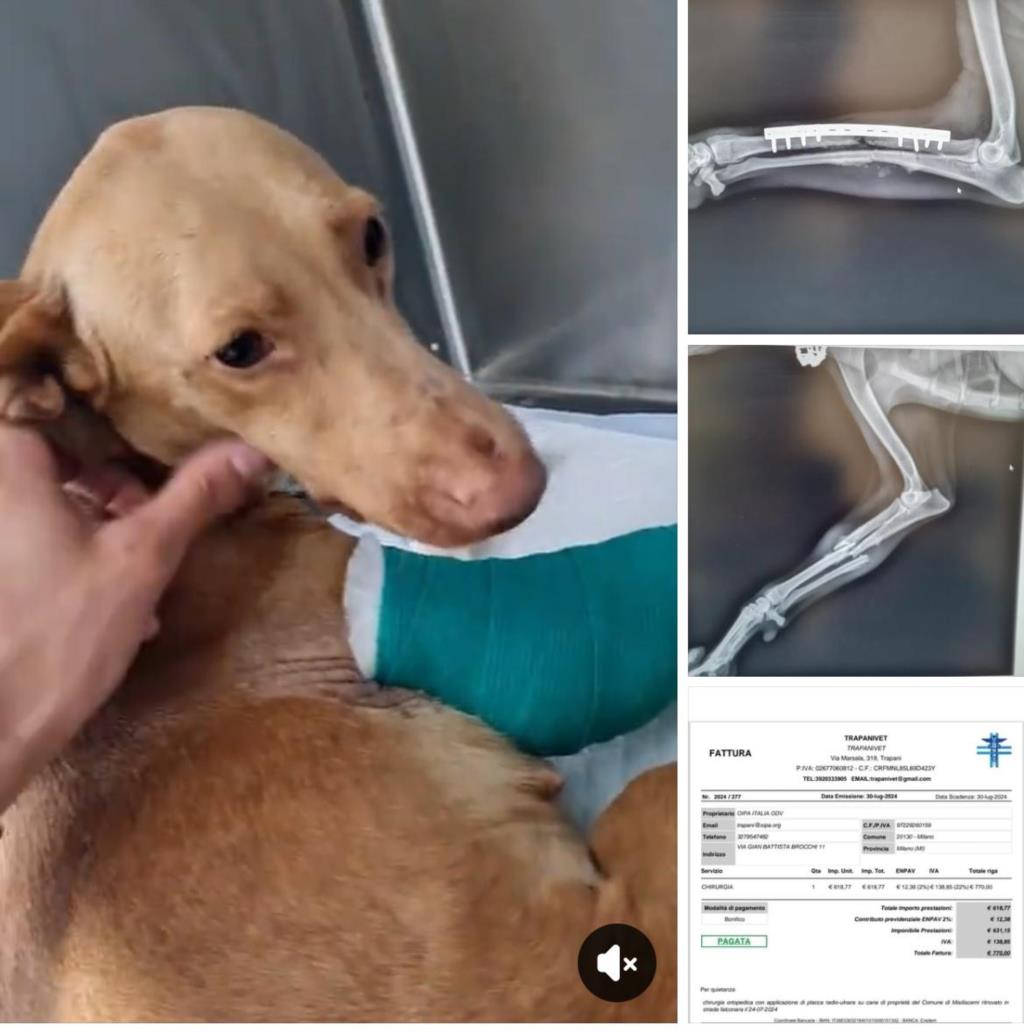


 Giusy Lombardo
Giusy Lombardo



