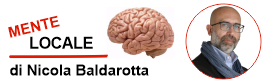Trapani, Erice e la rettifica dei confini
Da oltre mezzo secolo si parla e si discute. L'argomento è ancora sul tavolo
L’atipicità territoriale riguardante Trapani ed Erice la conosciamo tutti. Complicata e annosa. Si dice sempre così. Ma anche associata alla mancanza di una reale volontà a volere risolvere sul serio il problema, peraltro affatto unico nel panorama amministrativo nazionale. La questione, perciò, che magari parrebbe una peculiarità nostrana, nella casistica amministrativa è una bizzarria ben precisa trattata nell’etichettatura di “centri divisi”.
Il reticolo delle circoscrizioni comunali italiane è dimostrato infatti dall’esistenza di varie centinaia di abitati divisi tra due o più comuni, situazione che, con tutti gli inconvenienti del caso, fece di Trapani, e in tanti se ne ricorderanno, un “centro diviso” addirittura in tre fino alla risoluzione con Paceco (atto definitivo n. 199 del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 6 dicembre 1978).
In genere però, altrove le appendici appaiono solitamente modeste, questo sì.
Trapani ed Erice rappresentano invece un’eccezione dal punto di vista dell’elevato numero di abitanti “ericini” che di fatto vivono a Trapani, giù, a valle, in una città che è un continuum di fatto.
Volendo ulteriormente esemplificare il concetto, qualunque persona ignara dell’anomalia, trovandosi, che so, dalle parti dell’ospedale, mai immaginerebbe di non trovarsi a Trapani.
La continuità urbanistica della città non suggerisce quindi nulla. Solo che il Comune di Erice esercita la propria giurisdizione amministrativa e fiscale sulle popolate zone “trapanesi” meglio identificate col nome Casa Santa, vasto agglomerato che non ha invece alcuna soluzione di continuità territoriale e urbanistica con la vetta, con la cittadina Erice che, a prescindere dalla esigua distanza chilometrica, rimane lo stesso distante.
Il problema è sul tappeto dal 1856. Da circa mezzo secolo la soluzione attraverso la semplice, semplice per modo di dire, rettifica dei confini, è stata ciclicamente presa, accantonata ripresa e ora pare definitivamente accantonata.
A prevalere infatti è l’idea della Grande Città, da diversi mesi narrata con piglio più deciso rispetto a qualche anno fa, quando per la prima volta se ne parlò.
I comitati pro, frattanto costituitisi (unitamente a quelli contro) hanno messo in fretta da parte qualsiasi remora e attenzione di natura identitaria - i campanili non c’entrano e sarebbero oltremodo ridicoli - sposando ovviamente la causa e auspicandone il buon fine, ovviamente dal loro rispettabile punto di vista.
Da Erice infatti giunge un appello: “Salvate il Monte Erice, la dea Venere e la vera Cultura, ve ne saremo grati”. Lo scrive il signor Francesco Maria Saluto, ericino doc, fortemente, quasi fatalmente legato alle proprie origini.
Lo scrive a margine di un’accorata e circostanziata lettera divulgata qualche settimana addietro, invocando i “patrioti ericini” e accusandoli, in un certo senso, per l’agonia di Monte San Giuliano.
La Grande Città? Praticamente bocciata. Motivazioni storiche, culturali, identitarie, a supporto. Unitamente ai sotto riportati numeri da proporre a quanti optano per la sparizione del comune di Erice alimentando l’alibi dell’esiguità dei suoi abitanti.
Tanto per cominciare Floresta, amenità in provincia di Messina posta a 1275 d’altitudine: 451 abitanti. Quindi Sclafani Bagni e Campofelice di Fitalia (Palermo) che di abitanti ne contano rispettivamente 350 e 467; Roccafiorita addirittura 187, località tutte e tre assestate a poco oltre i 700 metri d’altitudine.
Non solo numeri, però.
Erice ha la sua storia. Una storia ultramillenaria accresciuta dalla bellezza praticamente integra della sua urbanistica e architettura sacra e civile. Sono peculiarità di grande rilevanza accresciute dal fascino delle risorse naturali e paesaggistiche. E perciò il presunto valore politico-amministrativo, il paventato circuito geo-politico, finirebbero con l’esporre la città del monte “ai venti della sub-cultura”. Che a volere pensar male, significa che ragionando ormai i politici, politici e amministratori in genere, in termini numerici di voti, in estrema sintesi Erice ne potrebbe restare ciclicamente esclusa quando poco appetitoso risulterebbe il bacino elettorale del momento in favore di questo o quel candidato di turno.
“Il circuito dei comuni elimo-ericini è una favola raccontata male”, perciò egli scrive pure.
La frantumazione della Storia e del Mito significherebbe sminuire Erice a vantaggio di cittadine circostanti, magari foriere di maggiori garanzie… elettorali.
Ecco allora l’alternativa: proporre Erice quale sito del Patrimonio dell’Unesco.
In Sicilia ve ne sono sette; nessuno nella provincia di Trapani.
Erice possiede i requisiti a poterlo diventare e sarebbe uno salto di qualità che oltretutto aggirerebbe la politica che non potrebbe più amministrare direttamente, diventando appannaggio dell’Unesco le norme che ne disciplinerebbero la conservazione e la tutela.
Esempio recente di candidatura in tal senso la cittadina laziale di Civita Bagnoregio, in provincia di Viterbo.
Per la cronaca, il 21 gennaio di quest’anno, l’amministrazione comunale ha avviato, assieme alla Regione Lazio, in collaborazione con il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la candidatura. Il Comitato Unesco dovrà esprimersi entro il 2022 e i suoi pochi abitanti ne attendono il responso. E perciò il quesito diventa elementare, perché Civita Bagnoregio sì ed Erice no?
Bene, la soluzione prescinde dunque dalla Grande Città e non pare possa trovare ostacoli nella rettifica sic et sempliciter dei confini. Solo che da troppo tempo si sono voluti mascherare interessi nel volere andare a fare, con l’ottenimento di pochi volti, il sindaco o l’assessore al Monte per poi gestire l’ampio territorio che non è certo sulla vetta ma a Trapani. In qualche caso inoltre, ricoprire ad Erice determinati ruoli politici ha significato farne trampolino di lancio per altre e più ambiziose cariche. E perciò rimarrebbe difficile giungere ad accordi a fronte di una materia amministrativa complessa, quando l’argomento si chiama rettifica dei confini, nel senso dell’accorpamento a Trapani dei territori di Casa Santa. Eppure, è la linea più ragionevolmente perseguibile al fine di salvaguardare le distinte identità e diversità storiche e culturali che fanno di Trapani ed Erice due entità semmai forzosamente e forzatamente riassumibili in una innaturale unicità.
Per Trapani l’incremento territoriale e di conseguenza del numero di abitanti darebbe linfa a una città capoluogo agonizzante non meno di Erice che, divenendo Patrimonio dell’Unesco, manterrebbe una dignità autonoma e identificativa di un mondo a parte depositario di altre storie, altri vissuti.
Semplice rettifica dei confini dunque.
Costi quel che costi a buon senso e perseveranza.




 Redazione
Redazione