Amarsi a Pompei
di Jo March
Una luna piena, luminosa e chiara stendeva un velo di luce azzurra lungo la via dell’Abbondanza, rendendo lucido l’antico basolato e creando fitte ombre all’interno delle domus, che si susseguivano senza interruzione, lungo la strada. Nella città sepolta l’atmosfera era magica.
Si armò di santa pazienza, Ciro.
Passare la notte a guardia dell’ultimo ritrovamento degli scavi, non era quello che avrebbe fatto volentieri, neanche per il compenso straordinario che gliene sarebbe venuto in tasca. Ma così era.
I suoi passi solitari, nel silenzio della sera, risuonavano di un’eco lontana. Faceva il custode Ciro e, spesso, anche la guida ai turisti nel sito, conosceva tutti gli angoli della città e, ormai, era tanto abituato al fascino del luogo, che non vi faceva più caso.
Nella mattinata, c’erano stati trambusto ed eccitazione tra gli studiosi e gli archeologi, per un nuovo ritrovamento sotto del pavimento di una domus. Un vuoto, tra la spessa coltre di cenere compatta, denotava la presenza in quel luogo, di qualcosa che col tempo si era dissolta, lasciando un’impronta. Una colata di gesso aveva colmato il vuoto e l’indomani sarebbe stata portata alla luce liberandola dai detriti che la circondavano.
Alla fine del primo giro d’ispezione, Ciro si fermò a riposare proprio dinanzi all’ingresso della domus, seduto sul marciapiedi, sbadigliò e si appoggiò al muro, cercando una posizione comoda per dar sollievo ai piedi affaticati, ma un rumore proveniente dall’interno della casa lo fece subito scattare in piedi. “Chi va là!” gridò e si lanciò all’interno. Illuminò con la torcia gli ambienti, ma erano tutti deserti, frugò con gli occhi ogni angolo, poi si voltò per tornare fuori. Sfiorò con il piede il bordo dello scavo, che franò sotto il suo peso e lo fece sprofondare all’interno, proprio sulle assi di legno che proteggevano la colata di gesso. Ciro perse i sensi, o così gli parve … e sognò.
***
Lungo la via delle Scuole, verso mezzogiorno, Glauco si avviava per giungere alla palestra dei gladiatori, doveva andarvi per allenarsi alla lotta contro i leoni. Avrebbe combattuto e ucciso quelle belve. Doveva farlo, era l’unico modo per conquistare il premio in sesterzi e la corona d’oro di campione.
Sorrise al pensiero di poterla posare sui capelli di Clelia, così non sarebbe più stato solo uno schiavo, un gladiatore senza nome, la vittoria gli avrebbe dato il diritto di cives e l’avrebbe sposata. Suo padre non avrebbe più potuto opporsi; vincere i leoni nell’anfiteatro lo avrebbe reso un eroe, quasi una divinità e lo avrebbe anche reso ricco.
Pensava a lei, alle sue bianche braccia che lo avvolgevano, quando, nei loro incontri brevi, troppo brevi e furtivi, i loro fiati si fondevano, i suoni trattenuti, i sospiri affrettati, le parole, sussurrate sulla pelle, rivelavano il desiderio di appartenersi sempre, sempre.
Un fremito della strada lo riportò alla realtà, da giorni ormai brontolii e sussulti giungevano dalle viscere della terra, era assuefatto alla presenza del vulcano, che di tanto in tanto faceva sentire la sua voce. In quei momenti tutti alzavano lo sguardo verso quel dio incombente sulla città ed esso sbuffava, di solito, una lunga fumata bianca e si acquietava, come a rassicurarli della sua benevolenza.
Giunse alla palestra, vi rimase ad allenarsi fino a sera, con reti, forconi, lance, e lunghe spade e, come gli altri gladiatori, ne faceva un uso magistrale. Alle prime ombre della sera, i gladiatori lasciarono la palestra e uscirono sulla via lastricata, una nuova scossa, seguita da un brontolio, li lasciò inquieti, sul Vesuvio un bagliore rossastro e una densa nube gialla si alzavano verso il cielo e, col vento, giungeva un intenso odore di zolfo.
Era il ventesimo giorno prima delle kalende di novembre, mancavano due giorni allo spettacolo nell’arena dell’anfiteatro, ancora due giorni per rivedere Clelia. Lei sarebbe certamente venuta ad assistere al suo trionfo, poi si sarebbero incontrati, mentre a Pompei ancora si faceva baldoria. La sera tiepida lo indusse ad indugiare prima del rientro, si fermò a bere e mangiare in un termopolio, dove l’oste gli servì carne di maiale e una ciotola di vino, insieme ad una schiacciata di cereali e miele.
La notte trascorse senza scosse, ma al mattino, una leggera nebbia rada e giallastra velava il cielo. Uscì dall’insula, di cui abitava il piano alto e si recò sulla via dell’Abbondanza, dove sperava d’incontrare Livia, l’ancella di Clelia e, per mezzo di lei, aver notizie della sua amata.
La strada pullulava di gente, mercanti e schiavi affollavano i marciapiedi, carri pieni di merce, provenienti dalle vicine campagne, facevano stridere le ruote sul selciato, ricche matrone, seguite da ancelle, si recavano al mercato, sfaccendati sostavano davanti alle mescite d’acqua e cibo da strada. Una giovane donna serviva ai passanti vino, in ciotole di terracotta, gli avventori chiassosi scherzavano con lei e le rivolgevano salaci battute. Ogni tanto, il marito si affacciava a minacciare quelli più intraprendenti: “Via, via, fannulloni, qui si lavora!”, poi rivolgendosi alla moglie aggiungeva: “E tu, vieni dentro, sto io a mescere dalla strada. Non ti ho sposata, pagando, a quel buono a nulla di tuo padre, mille sesterzi, perché facessi la civetta coi clienti”. I due erano quanto di più diverso si potesse vedere in una coppia; lui anziano, grasso e burbero, lei giovanissima e vivace.
In quel momento, Livia gli passò accanto e, sfiorandolo, gli consegnò un biglietto. Lo tenne stretto nel pugno, nascosto sotto il corto mantello e si appartò per leggerlo.
“Dove sei adesso, mio Glauco, ti vedo, con gli occhi della mente, camminare per strade luminose. No! Non guardare altre donne, sai che sono gelosa. Tu pensa solo a me. Stento a trattenere il mio piede che continuamente si volge verso la porta, il desiderio di raggiungerti lo muove, il cuore lo spinge e la volontà di trattenerlo vacilla. Due giorni d’attesa mi uccideranno. Vieni ti prego all’uscio del mio giardino, nel vicolo buio, stanotte nessuno ci vedrà, Livia veglierà, per proteggere il nostro incontro”.
Da lontano, Glauco fece un cenno verso Livia, a confermare l’appuntamento.
La notte, nel vicolo deserto, egli parlò a lungo delle sue speranze: “Vedrai, io vincerò nell’arena, sarà il mio giorno di gloria, mi poseranno sulla testa la corona d’oro ed io sarò un ricco cittadino romano, potrò averti come sposa e non ci nasconderemo più. Quel giorno verrò da te per posare sulla tua testa la mia corona, sarai la mia regina”. Clelia lo ascoltava e rideva piano per non far rumore, con gli occhi scintillanti di gioia, nell’oscurità. Poi si lasciarono.
La mattina del ventiquattro ottobre l’anfiteatro era al colmo della sua capienza. Fin dall’alba i pompeiani si erano accalcati per occupare i posti migliori nelle gradinate. Lo spettacolo, che da lì a poco sarebbe iniziato, era eccezionale. Alle nove i gladiatori erano già scesi nell’arena per le lotte con le armi, ma tutti gli spettatori attendevano solo Glauco e i leoni.
Quando entrò nell’arena, un urlo si levò dagli spalti e il cuore di Clelia, tremò. Glauco, armato di una rete e di una lunga spada, alto ed imponente, attese che si aprissero le grate e uscissero i due leoni. Le belve, incitate dalla folla, si aggirarono, dapprima confuse, poi ruggirono spaventate dalle urla, infine si avventarono contro il gladiatore. Con destrezza Glauco lanciò la rete su una di esse, che rimasta impigliata tentava vanamente di liberarsi, mentre l’altra con un balzo gli si gettò contro, ma la spada lunga gli squarciò il ventre prima che atterrasse. Fu facile, poi, sbarazzarsi dell’altro leone, che ancora tentava di liberarsi dalle maglie della robusta rete di corda.
Lo spettacolo era durato pochi minuti, la folla era in delirio, quel gladiatore era acclamato come un dio e fu il console della città a consegnargli la borsa colma di sesterzi d’oro e ad incoronarlo come eroe del giorno.
Era passato da poco mezzogiorno e la folla lasciava lo stadio sperdendosi per le vie della città, era un giorno di festa, canti e risate, i festeggiamenti sarebbero durati fino a notte.
Glauco messo al sicuro il suo tesoro, con la corona nelle mani, correva ad incontrare Clelia. La vide da lontano corrergli incontro con le braccia alzate sopra la testa e la tunica svolazzante, rideva felice: il loro futuro appariva splendido. Si abbracciarono, ma subito lei storse il naso: “ Il mio sposo, olezza di sudore e sangue. Subito alle terme!”
Nella tiepida e profumata acqua del calidario si immersero nudi, lui le sciolse le trecce, le pose in capo la corona d’oro e la baciò dolcemente. Fu un attimo … un boato terribile riempì l’aria, era passata l’una da qualche minuto. Prima che i due comprendessero cosa stava accadendo, un terremoto scosse la terra, le mura delle terme crollarono, investite da un vento di fuoco, cenere e lapilli incandescenti si riversarono sull’edificio sommergendolo completamente. L’urlo nato dal loro petto fu spento dalla cenere che riempì le loro bocche aperte.
***
Ciro si svegliò di soprassalto, tremava di terrore, quel sogno orribile l’aveva sconvolto. Si accorse d’essere caduto dentro lo scavo e, pieno d’angoscia, a forza di braccia si tirò fuori. Usci all’aperto, era l’alba, seduto sul marciapiedi si asciugò il sudore che gli bagnava il viso e il collo, poi si voltò a guardare la penombra della casa ed ebbe un brivido. “Che stupido, disse ad alta voce, se lo raccontassi riderebbero di me e direbbero che ho bevuto troppo”, così vergognandosi della sua paura, bevve un sorso del caffè che si era preparato la sera prima e cominciò il primo giro d’ispezione della città. Ritornò su luogo dopo qualche ora, gli archeologi e gli operai stavano lavorando, avevano già liberato il calco dallo scavo e lo stavano deponendo sul pavimento per ripulirlo dalla terra che lo avvolgeva. Ciro si avvicinò per guardare i lavori. Mano a mano che il calco veniva fuori dall’involucro si riconoscevano le forme sepolte e il viso di Ciro diveniva sempre più pallido. Due corpi abbracciati, i visi volti in alto, le bocche spalancate e, quando l’ultima zolla di cenere cadde, si vide sulla testa della figura più piccola, forse una donna, un oggetto di metallo dorato, quasi del tutto fuso, una corona. Gli archeologi erano molto sorpresi: un mistero su cui indagare. Solo Ciro resto in silenzio e una lacrima scivolò sulla sua guancia.



 Redazione
Redazione

 Carmela Barbara
Carmela Barbara



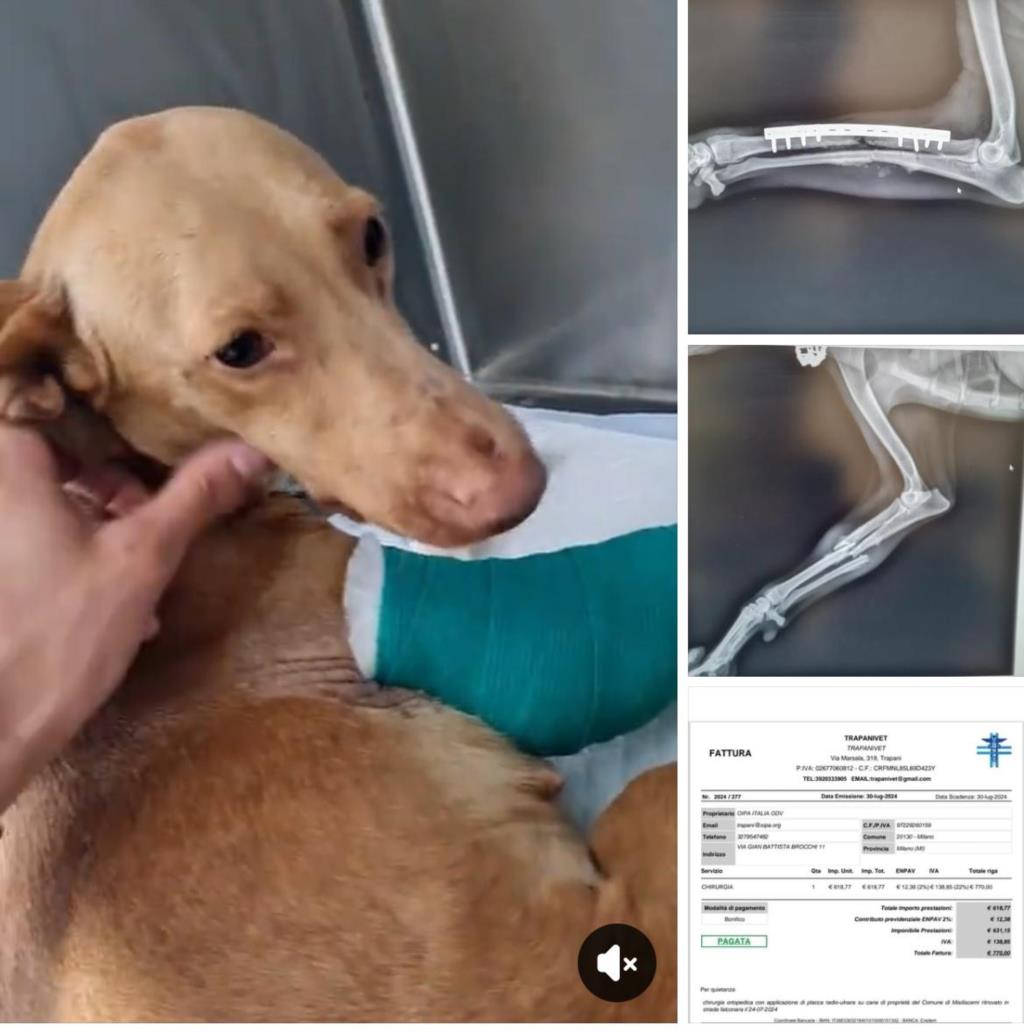


 Giusy Lombardo
Giusy Lombardo


